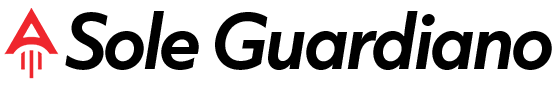Sapere quando fermarsi è una grande dote e un privilegio di pochi. Lo è in termini creativi, seppure ci sia misura anche nell’eccesso, perché è solo lo sbraco senza cura che equivale a poco pensiero; lo è in termini professionali, perché la consapevolezza che si è moderni una sola volta sola nella vita ed è meglio lasciare al picco che continuare stancamente fino all’irrilevanza è segno di saggezza. La tornata del prêt-à-porter maschile si è chiusa a Parigi nel segno del fermarsi per tempo.
Dries Van Noten si ritira dalle scene a poco più di trent’anni dalla prima sfilata e a quasi quaranta dal lancio del marchio che porta il suo nome, fondato nel 1986. Quello di sabato sera è stato il suo centoventinovesimo show: come tutti i precedenti un misto di emozione, sorpresa, monumentalità. L’occasione speciale, però, non ha scatenato nessuna nostalgia, nessun “dopo di me il diluvio”, nessuna ricapitolazione di stilemi e segni. Al contrario, dice Van Noten, «come in tutte le sfilate lo sguardo è rivolto in avanti».
Pronto a lasciare la direzione creativa ma non l’azienda che porta il suo nome, dove manterrà il ruolo di advisor, Van Noten, 66 anni, lavora alla collezione con il pragmatismo di sempre, senza pomposità autocelebrative, e già per questo se ne apprezza la statura, possente e gentile. Presentata in un capannone di periferia, su una passerella di foglie d’argento che ansimano a ogni passo, la collezione è Dries al suo meglio, ossia maestro del colore, della stampa, della forma che avvolge, con l’accelerata futurista delle materie metalliche, delle velature sintetiche, delle dorature e argentature. La sfilata sfuma in un party con gigantesca palla di specchi, mentre Dries esce di scena lieve, in smagliante forma creativa, senza una lacrima.
L’esercizio di moderazione compiuto da Jonathan Anderson per Loewe è di altra natura, ed equivale a vergare un segno stilistico netto e sicuro, vibrante di tensioni, puro e personale nell’intento. Anderson gioca con la scala delle cose, e sui significati che scaturiscono associando gli oggetti. Il colpo d’occhio, entrando nella sala della sfilata, è forte: uno spazio immenso, vuoto, punteggiato di oggetti provenienti dalla collezione personale di Anderson. Sono arredi e pezzi d’arte – una foto di Peter Hujar, la half moon chair di Charles Rennie Mackintosh, un cavalletto di Carlo Scarpa – e il libro “Against Interpretation” di Susan Sontag, ma da lontano potrebbero anche apparire come modelli di edifici, o il disegno di una città. Il vuoto pesa quanto il pieno. Ugualmente, la collezione è un contrappunto assai teso di pieni e di vuoti, marcato da una verticalità spiccata e da una corporeità a dir poco allampanata.
C’è all’opera il gusto di Anderson per il volume astratto, per le forme che ondeggiano, ma questa volta tutto si asciuga nel grafismo degli abiti neri e delle scarpe allungate, delle tute aperte sui fianchi da incroci magici di cinture, dei top di madreperla o di catene oro intrecciate, nel profilo di camicie che sembrano tagliate con il goniometro. Poi ci sono i pantaloni di maglia che ballonzolano come crinoline, e le piume che, in forma di maschera e puntate al basso, nascondono il volto. Anderson lavora sulla ripetizione di pochi elementi e lascia che il messaggio sia una silhouette, ossia un distillato di moda ridotto all’essenza che perdura: la linea. Colpisce la ricchezza dell’espressione nella scelta formale della limitazione.